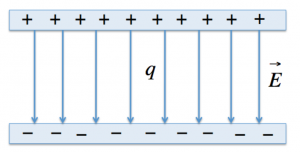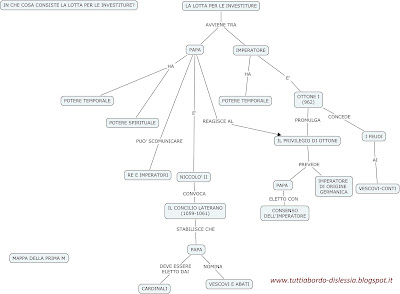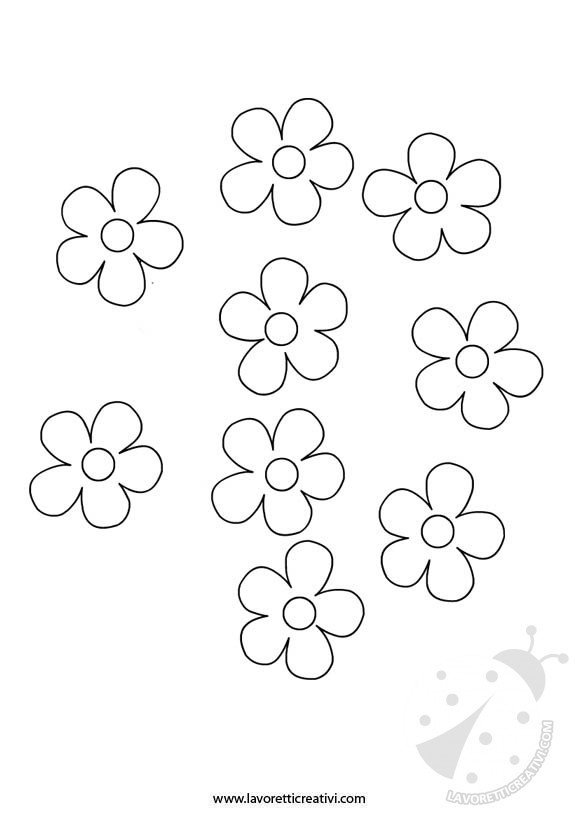Pubblichiamo un articolo di Francesco Forlani, uscito sulla rivista «il Reportage», su Sergio Atzeni.
di Francesco Forlani
Ci vogliono dieci ore di traversata in mare. Genova-Porto Torres. È il 25 dicembre, Natale. Per far passare il tempo mi sono portato una copia del “Viaggio al termine della notte”. Con Ernesto Ferrero, che l’aveva tradotto, abbiamo tenuto una conferenza alla Biblioteca civica di Torino. Lui su Céline, io su Cendrars. Ernesto Ferrero era molto amico di Sergio Atzeni. Quando gli chiedo di mandarmi un suo articolo del 25 aprile 1996, intitolato “Gli sciamani di Sardegna”, insiste su un particolare: “Sai, siamo stati suoi ospiti a Carloforte e ancora non ci sembra vero, a me e mia moglie, ancora oggi a tanti anni di distanza, che sia morto annegato. Aveva un fisico da nuotatore, insomma spalle larghe”. Il 6 settembre del 1995 Atzeni aveva trovato la morte nel mare dell’isola di San Pietro. Carloforte. Tra gli scogli della Conca. Ma l’aveva cercata?
Le porte dell’Isola
Ci sono delle città che per storia vanno conquistate scegliendo con attenzione da quale porta entrare. A Parigi bisogna arrivare dalla Porte d’Italie, a Venezia da Jesolo. In Sardegna è sicuramente Porto Torres, l’immagine sfocata della terra all’orizzonte che la fa apparire come una costa atlantica, il luogo di destinazione migliore. Ad attendermi c’è Giovanni Cossu con cui prenderò un caffè insieme agli altri naviganti e che poi mi accompagna alla stazione con un solo binario e un nuovo treno, che il capostazione non riuscirà a far partire subito. Giovanni è il primo scrittore sardo che incontro. Proprio su Porto Torres ha scritto il suo più bel libro, Turritani. Di Atzeni mi dice che il suo capolavoro è Bellas Mariposas. Si narra la storia di due ragazzine che sembrano uscite da un episodio di Ranxerox, la splendida bande dessinée di Stefano Tamburini e Tanino Liberatore. Le lingue che il racconto mette in campo sono il fulgido esempio di una letteratura che fa a meno della lingua dominante, l’italiano, la “creolizza”, la contamina con il sardo campidanese, a sua volta declinato nello slang delle periferie urbane. Al momento di lasciarci, Giovanni mi consegna alcuni fogli. Sono le lettere di Gadda da Portovesme. Di fronte all’isola di Carloforte. Dove terminerà il mio viaggio. Parlano delle due centrali elettriche. Atzeni lavorava all’Enel prima di abbandonare l’isola.
Quando arrivo a Sassari, ad accogliermi alla stazione è Lalla Careddu. Non ci siamo mai incontrati di persona prima d’ora, ma so che casa sua è un libro, dove vengono spesso ad abitare gli scrittori ospiti del piccolo festival Cabudanne de sos poetas. Mi dice che Sassari è un gomitolo di sarcasmo ironia e disincanto: “Molti si sono appiccicati ad Atzeni per farsi promotori di una sardità pretestuosa e finta. Atzeni diceva di sé sono sardo ed europeo. Alla Soriga o Abate, tanto per fare due esempi”. Dal vicolo Luzzati alla Piazza Italia dove mi verrà a prendere il mio amico e mentore Marco Murgia è tutta una salita, Sassari è una città in salita. Scoprirò poi che Nuoro è una città in discesa. Lalla conosce tutti a Sassari e tutti la salutano per quella piazza così centrale e luminosa, assolata a dicembre. Quando Marco arriva facciamo festa. Eravamo compagni di collegio e si sa che quando si è amici nelle camerate si è amici per tutta la vita. Faremo prima tappa dai suoi suoceri a Sorradile di fronte al lago Omodeo, che sembrala Svizzera. Poi andremo a Nuoro e finalmente a Orgosolo.
“Banditi a Orgosolo”
A Orgosolo non ero mai stato. Eppure i suoi murales mi sono familiari quanto lo struggente manifesto del film di De Seta, quanto gli affreschi di Pompei. Un museo en plein air di tutte le rivoluzioni. Ma senza la pesantezza statica delle collezioni che si incrociano tra le sale del Louvre o del Reina Sofia. Qui i ritratti di operai e pastori in rivolta sono inchiodati ai muri e infatti sanguinano. A Orgosolo Atzeni ha trascorso parte della sua adolescenza, dalle scuole medie al liceo, con una presenza che non l’abbandonerà mai per tutta la vita: “Quando ero piccolino – scrisse – mia nonna mi leggeva i racconti di Grazia Deledda e quanto quei racconti mi abbiano influenzato, non lo so”.
Con Marco andiamo a pranzo da un suo amico, Pino Monni, che di mestiere fa l’allevatore. Il camino è acceso. Così come la sera prima dai suoceri, che si sgranava il mirto davanti alle fiamme e si rideva del cabaret appena visto alla televisione. Credo che si capisca una terra da come si ride, ho pensato. Infatti le persone incontrate a Nuoro per lavoro mi confermano la cosa. A Cagliari non si ride delle stesse cose di Nuoro. L’umorismo nuorese è più rabelaisiano, gaudente, carnevalesco, hot.
La mamma di Pino Monni si chiama Maria Antonia Farina ma la chiamano con il diminutivo di Mimia. Il piatto che mangiamo si chiama ma’arrone lados, ma’arrone sta per maccaroni, lados sta per piano, largo (il piatto piano si dice lados), e talvolta lados si dice di persona grassa. Si lascia la notte sul tavolo perché le anime di coloro che se ne sono andati possano nutrirsi. Quello che resta viene dato ai poveri. L’impressione è di vivere un’esperienza ancestrale, un rito antico, una voce che parla e dice comunità.
Nei prossimi giorni incontrerò le persone che hanno contato nella vita dello scrittore. So che dovrò farmi da parte e non prendere dalla tavola quello che appartiene alle anime di chi non c’è più. Davanti al fuoco, ancora un camino su cui bruciano le carni, si parla di Gavino Ledda. Pino ci racconta di come quel libro fosse stato necessario. Sua madre invece fa segno di no, quella storia l’ha rifiutata. Ha quasi ottant’anni, ma sembra una bambina. Ha modi degni, austera e insieme benevolente, severa e dolce come una maestra. Così me la immagino Gigina, la nonna di Atzeni. Di Gavino Ledda, Atzeni scrisse: “Un lettore d’oggi può trovare in Padre padrone di Gavino Ledda (romanzo realista se mai ve ne fu uno degno di tal nome) la metafora dell’impossibile compito che attende l’uomo di quest’epoca: farsi da bestia giudice di sé, del senso delle proprie parole, del mondo circostante?”.
A Cala Gonone, dove dormiamo dopo la tappa a Orgosolo, c’è una libreria con un intero comparto dedicato alla letteratura sarda. I libri di Atzeni, con l’unica eccezione di quelli pubblicati da Sellerio, e nemmeno tutti, non si trovano in continente. Così faccio man bassa dei titoli che leggerò strada facendo. Il quinto passo è l’addio, Passavamo sulla terra leggeri, Bellas Mariposas, Si…Otto (libello sul ’68 cagliaritano scoppiato negli anni 80), Racconti con colonna sonora e altri in giallo, I sogni della città bianca, quasi tutti pubblicati dal Maestrale di Nuoro, a cura di Giancarlo Porcu, uno dei migliori editor dell’isola. Però prendo anche altro. Michela Murgia, Flavio Soriga, Francesco Abate, una copia di “Padre padrone”, insieme a un libro intervista a Gavino Ledda. Scriveva Atzeni nell’autunno dell’81: “Ogni libraio sardo ha -perenne o stagionale- una vetrina riservata alle novità isolane. Una decina di anni fa si producevano meno libri sardi (…). Oggi le cose sono cambiate. Perché? La risposta, con sfumature diverse, esprime un concetto su cui i nostri interlocutori sono praticamente tutti d’accordo. C’è un tentativo faticoso di riappropriazione della cultura originaria da parte dei sardi. Un momento necessario nella ricerca di un’autonoma identità individuale e collettiva”.
Padri padri
Ci sono dei paesaggi che ti colpiscono per la loro immutevolezza. Nulla sembra cambiare, nemmeno chi li abita ed è per questo, forse, che si tracciano segmenti di tempo molto lunghi, tra una generazione e l’altra, perché ci si accorga del cambiamento. Qualcuno è morto, il ristorante in paese ha cambiato proprietà, però le case si tramandano insieme ai posti sulle panchine ficcate sulle pareti di roccia davanti alle strane montagne che fanno da corona al paese. Ci guardano come si osserva uno straniero, con un misto di curiosità e sospetto, una diffidenza che quasi ti aggredisce se una volta incrociato lo sguardo ci lasci gli occhi per un po’. Entriamo nell’unico bar aperto sulla stradina in salita di Siligo e, dopo aver ordinato un caffè, chiedo alla proprietaria se per caso il maestro Ledda è in città. Mi dice di sì, che siamo fortunati perché è stato appena dimesso dall’ospedale.
Ci andiamo in macchina e, non appena vediamo la porta, accostiamo. Gavino Ledda sta uscendo. Con piglio deciso lo avvicino con in mano la copia del suo romanzo. Gli dico che sono venuto da lontano per farmelo dedicare. Mi accoglie con gentilezza e mi invita a sedermi sulla panchina che è poco oltre. Dopo che mi ha firmato il libro gli chiedo se ha conosciuto Sergio Atzeni. “No, non ci siamo mai incrociati personalmente. Conosco il suo lavoro”. Poi aggiunge: “Da vent’anni sono su un’opera monumentale, vedrai, se ne accorgeranno. Un’opera che racconterà l’origine della mia terra, la lingua sarà quella dell’origine”. Mi ricorda, fisicamente, Pier Paolo Pasolini, ma anche Céline. Del primo ha gli zigomi alti, l’intensità dello sguardo. Del secondo il modo di camminare, che è quasi una danza. “Di Pasolini forse il fascino, la potenza dello sguardo, la sensualità”, mi risponde quando glielo dico. Gli chiedo se a distanza di anni quel padre c’è ancora. “Il padre del mio romanzo era il Padre assoluto, non quello che mi apparteneva, insomma il mio padre soltanto. Vedrai però, l’opera a cui sto lavorando rivoluzionerà tutto”.
Davanti a noi abbiamo una lunga strada da fare. A Siliqua ci aspettano Antonio Calledda, padre di Michela, Marinella sua madre e il cane Bardamu, come l’antieroe del Viaggio céliniano. Antonio era molto amico di Licio Atzeni, padre di Sergio e segretario del Pci del Sulcis. Aveva conosciuto Sergio Atzeni ai tempi della Fgci: “Ricordo di averlo incrociato alla Bolognina quando Occhetto annunciava la fine del Pci. Mi chiese di suo padre e io, come al solito, lo informai di come stessero andando le cose. Per anni ho fatto da Hermes tra i due, l’uno mi chiedeva dell’altro e viceversa, ogni volta. Mi ricordo come fosse ieri la prima del film di Gianfranco Cabiddu, Il figlio di Bakunin. Gli occhi di Licio erano lucidi, alla fine della proiezione”. Racconta: “La storia politica di Sergio era molto importante, lo era per tutti noi. Un ragazzo pieno di vita, che lascia l’isola dopo il fallimento del concorso in Rai. Fu una prima morte quella, per lui. Era riuscito grazie alle sue sole forze a vincere il concorso, sarebbe entrato in Rai e avrebbe coronato il suo sogno di giornalismo. Invece a Roma cambiarono le carte in tavola. Bisognava dividersi quei posti tra i partiti. Sergio, gli era stato promesso, sarebbe comunque entrato, dopo un anno, ma poi non fu così”.
L’approdo a Carloforte
A Carloforte ci arriviamo con un traghetto da Portovesme. Ce ne sono due che collegano l’isola all’Isola: Vesta e Sibilla. Il vento soffia a80 chilometriall’ora. Quando arriviamo capisco quello che mi ha detto Marco durante la traversata. Che i carlofortini parlano una lingua a parte, sono genovesi, non sardi. E, infatti, la focaccia ti dice Liguria dal primo morso. Il vento quasi ci trattiene nella salita a piedi che facciamo fino alla Conca. È incredibile (e spettacolare) come gli elementi si uniscano e pare che il mare vomiti neve. Fiocchi purissimi di sale che l’impatto con l’aria e la pietra condensa. Sembrano angeli. Uno poi rimane di sasso davvero quando ti vedi davanti uno scoglio che è “quello” scoglio, quando apprendi che Atzeni era rimasto aggrappato allo scoglio per quasi un’ora, mentre le motovedette dei carabinieri cercavano invano di salvarlo. Un’ora sotto gli occhi di tutti. Torniamo in città che è sera, buia.
All’Hotel Mediterraneo di Cagliari, l’indomani, mi aspetta Rossana Copez, la femmina sposa, da cui Sergio Atzeni ebbe una figlia, Jenny. Quando comincia a parlare davanti a un aperitivo glielo leggi negli occhi che compagni di vita significa prima di tutto la vita. Le chiedo se amasse la musica. “Credo che il suo sogno fosse proprio quello di scrivere canzoni – dice – suonava la chitarra, mi cantava sempre My lady d’Arbanville di Cat Stevens. Era molto legato a sua nonna e in qualche modo il legame alla Barbagia è sempre stato presente”. Ricorda che “un celebre bandito di quelle parti, coinvolto in un rapimento importante, gli aveva chiesto di scrivere un servizio su di lui per riscattare la propria storia. Sergio lo andò a trovare in carcere ma, quando dopo pochi giorni seppe della sua fuga, del ritorno alla latitanza, ne fu scosso, turbato, anche se non sorpreso”.
Le chiedo poi della “conversione”, come mi aveva suggerito Michela Murgia al telefono. “Non fu una vera conversione la sua – risponde Rossana – diciamo piuttosto un momento di raccolta, il bisogno di andare più a fondo in se stesso, arginare il dolore che le recenti sconfitte, soprattutto sul versante del lavoro, che per Sergio significava scrivere, per lui scrivere era tutto, gli avevano procurato. Il tradimento dei compagni, del partito, la storia del suo concorso in Rai, nel modo in cui avvenne, sperimentare sulla propria pelle lo scacco dell’idea di merito, lo aveva spinto a cercare un aiuto di tipo spirituale. Lo aveva trovato in una comunità che lo accolse dopo le sue dimissioni dall’Enel e prima di partire per il continente. Quanto alla sua idea radicale di scrittura ti racconto un aneddoto. Un giorno mi dice che ha scritto un intero romanzo e come capitava ogni volta mi chiese di dirgli cosa ne pensassi. Il testo, però, non mi convinse totalmente ed ebbi la malaugurata idea di confidargli le mie impressioni. Quando qualche tempo dopo gli chiesi a che punto stesse col manoscritto mi rispose tutto placido che l’aveva gettato, distrutto. È una cosa che non mi sono mai perdonata”. Le domando come sono andate poi le cose tra loro dopo la separazione. “Tutte le volte che tornava in Sardegna – risponde – rimaneva a casa mia, così poteva stare con sua figlia, condividevamo ancora molto. Non potrò mai dimenticare il giorno della sua morte. Aveva chiesto a nostra figlia di accompagnarlo a Carloforte e lei non aveva voluto. Sono quelle cose che ti rimangono dentro tutta la vita, domande del tipo: se avesse detto di sì le cose sarebbero andate diversamente?”.
Il giorno prima di rientrare a Torino, con Marco, passiamo alla Repubblica dei Libri, una libreria indipendente che raccoglie i migliori titoli e le case editrici della Sardegna. Prendo un caffè con i librai e al bar incontro, per caso, un altro eccellente scrittore sardo, Francesco Abate. Di Atzeni mi dice soltanto: “Il punto più alto”. E fa il segno con la mano. Nel pomeriggio vado a trovare Giorgio Todde. Con me Michela Calledda. Lo incontriamo in ospedale, lui è oculista e, a parere di molti, incontrati in questi giorni, una delle migliori penne dell’isola. “Sergio Atzeni – racconta – era nella mia sezione al liceo, ma di un anno più piccolo di me. Non l’ho mai conosciuto e al contrario del 90 per cento dei cagliaritani che dopo la morte hanno dichiarato di conoscerlo benissimo io non riesco a ricordare di averci parlato neppure all’ora di ricreazione. Per non dire di quelli che si sono impadroniti delle spoglie letterarie. Grazie a loro Atzeni è morto molto più di una volta. C’è chi si è costruito una carriera universitaria sulla sua morte”.
Torino, come Ritorno
Ero partito da Torino con le prime parole scambiate con Paolo Barsi, titolare della libreria Comunardi. Si conoscevano bene: “Atzeni e Paola, la sua ultima compagna, venivano spesso in libreria. Era una bella persona”, mi aveva detto. Nella sola biografia dedicata ad Atzeni (l’autore è Giuseppe Marci) non si fa menzione di Paola Mazzarelli. E non dico solo come sua ultima compagna, ma anche come curatrice di gran parte della sua produzione letteraria. Mi interesserebbe parlare con lei dell’attività di Atzeni come traduttore: l’incontro della sua poetica, da principio polifonica, sardo, italiano, slang cagliaritano, invenzione linguistica, si rinnova attraverso la lingua francese, che peraltro gli darà da vivere a Torino, dove si trasferisce dopo una breve parentesi nel parmense.
Accade che il giorno stesso del mio rientro passo alla libreria Torre di Abele per scambiare due parole con Rocco Pinto. Mentre discutiamo di Atzeni entra un signore elegante e a quel punto Rocco esclama ad alta voce: “Stavamo proprio parlando di Paola. Francesco, ti presento suo marito”. Un paio di giorni dopo sono a casa loro. Paola è una donna solida, femminile, quasi anglosassone. Di grande cultura. Le racconto del viaggio in Sardegna, di Carloforte, dei miei incontri. E le chiedo di parlarmi del rapporto di Sergio Atzeni con Torino.
“Questa città rappresentò per Sergio – risponde – una duplice possibilità. Da una parte quella di sperimentare la giusta distanza con i luoghi d’origine, ai quali l’opera non poteva rinunciare, infatti tutta l’opera di Sergio è ambientata in Sardegna, che si tratti di poesie, racconti, romanzi, articoli. Dico la giusta distanza perché quando viveva a Cagliari era come soffocato, prigioniero di un incantesimo, e per quanto doloroso fosse il distacco, cronaca al minuto nel Quinto passo, quel dolore aveva reso possibile l’accesso alla propria più autentica poetica. La seconda possibilità è stata quella di poter frequentare, grazie alle persone che ha incontrato, la comunità letteraria, di raggiungere cioè una dimensione non solo direi nazionale rispetto a quella regionale, ma addirittura trans-nazionale, grazie proprio al suo lavoro di traduttore”. Allora le chiedo se, a questo proposito, ci sono degli episodi che le piacerebbe raccontare. “Sicuramente quella volta che incontrò l’ex regina. Aveva lavorato alla traduzione delle memorie di Maria José di Savoia, intitolate “Giovinezza di una regina” e, dunque, doveva incontrarla per controllare insieme la traduzione. Ma il protocollo richiedeva una particola attenzione alla mise. Fu così che passammo la giornata a provare l’abito con la cravatta, con grande ilarità di tutti”. Sono molte le cose che ci diciamo. Al momento di andare le chiedo dove vivessero quando erano insieme. “Proprio qui”, risponde.